Relazione al convegno “Confronto o Conflitto tra le generazioni?” (24/11/2004 – N. Galloni)
Convegno del 24/11/2004
Indice
- LA RIFORMA DELLE PENSIONI IN ITALIA E L’IMPOVERIMENTO DELLA POPOLAZIONE
- PENSIONI OBBLIGATORIE, MERCATO DEL LAVORO E RENDIMENTI DEL CAPITALE
- MERCATO DEL LAVORO E PENSIONE
- SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
- ALTERNATIVE: IL MODELLO INPDAP?
****
LA RIFORMA DELLE PENSIONI IN ITALIA E L’IMPOVERIMENTO DELLA POPOLAZIONE
Relatore: Nino Galloni
Relazione
La contribuzione pensionistica – volontaria o obbligatoria che sia – costituisce parte integrante della retribuzione del lavoratore ovvero del costo del lavoro per le imprese. Per tale ragione, affrontare il tema delle pensioni in modo avverso all’andamento dell’economia e dei cambiamenti attraversati dal cosiddetto mercato del lavoro, rappresenta un comportamento irragionevole e causa di conseguenza e impatto sociale fortemente negativo.
In effetti, soprattutto in Italia, ma non solo in Italia, le autorità e una parte degli studiosi da esse enumerati, hanno considerato aspetti finanziari (di equilibrio nei conti degli Istituti pensionistici) variabili indipendenti (come se si potesse agire su di esse direttamente onde ottenere risultati stabilizzabili nel tempo: invece le uscite degli enti previdenziali e i livelli delle pensioni, influiscono sulle entrate – vale a dire i versamenti obbligatori o volontari – perchè costituiscono una componente sempre più rilevante, nelle nostre economie, della domanda effettiva di beni e di servizi).
In effetti, il dibattito sulla previdenza obbligatoria caratterizzata dal cosiddetto metodo a ripartizione (vale a dire gli occupati correnti che pagano le pensioni ai ritirati correnti) si apre, in Italia e in Europa, all’inizio degli anni ’80 quando si registrarono tre concomitanti fenomeni:
- 1) il cosiddetto invecchiamento della popolazione sia nel senso che – esauriti gli effetti del baby boom degli anni precedenti – i futuri lavoratori sarebbero diminuiti rispetto al numero dei futuri pensionati, sia nel senso che – con l’aumento della speranza di vita – sembrava più difficile gestire il sistema a ripartizione,
- 2) L’aumento della disoccupazione industriale e intellettuale, la rigidità del mercato del lavoro che sembravano favorire l’economia sommersa (dove si evadevano i contributi obbligatori), il peso decrescente della produzione e dell’occupazione rispetto alla finanza più o meno speculativa;
- 3) La crescita vertiginosa dei tassi di interesse reali che suggerivano di valorizzare il capitale fuori dal circuito produttivo (il che approvava il fenomeno della disoccupazione o, meglio, dell’insufficiente crescita dell’occupazione.
Le fosche previsioni degli anni ’80 che cominciarono a suggerire misure di restrizione della spesa pensionistica (aumento dei contributi, slittamento dell’età alla pensione, irrigidimento dei requisiti per ottenere la pensione) erano finalizzate a pompare il mercato finanziario speculativo: infatti si voleva costringere la classe lavoratrice e tutti i ceti produttivi ad investire in attività finanziarie per implementare pensioni in prospettiva sempre più misere.
I conti che si facevano durante gli anni ’80 erano basate sui tassi di interesse obbligazionari che arrivarono addirittura al 16% in termini corrente con uno “spread” rispetto all’inflazione di 7-8 punti.
Quando all’inizio del decennio successivo (settembre 1992), il sistema monetario europeo andà per aria – e non poteva che essere così perchè era organizzato in modo di indebolire la base occupazionale e produttiva dei paesi più deboli, come l’Italia – i tassi di interesse reali nelle obbligazioni si ridussero repentinamente. Così, gli investitori istituzionali e i fondi pensione, per mantenere gli impegni presi con i sottoscrittori di obbligazioni durante gli anni ’80, acquisirono nei loro portafogli pacchetti azionari di controllo dei principali gruppi industriali e imposero la managment di conseguire tassi di profitto del 7-8% (cioè pari a quelli di interesse del decennio precedente, un decennio completamente fuori dalle medie statistiche). Questi risultati furono facilmente realizzabili – durante gli anni ’90 – nei comparti più innovativi, ma richiesero strategie di taglio della produzione e dell’occupazione (delle spese di ricerca e sviluppo, ad esempio) nel 60-70% dell’economia.
Cosè l’occupazione si ridusse nei settori storicamente a maggiore valore aggiunto e, con essa, i redditi dei lavoratori più stabili; ci furono, quindi, meno risorse per le pensioni e, soprattutto, meno risorse per pagare – da parte degli stessi lavoratori – quei servizi (specialmente di cura delle persone e dell’ambiente) che hanno visto, invece, una crescita occupazionale, ma con salari e stipendi più bassi. I risultati di tutta questa situazione sono stati i seguenti:
- 1) già alla fine della primavera del 2000, la spinta propulsiva dei settori innovativi si esaurì prematuramente causando lo sgonfiamento della bolla speculativa in borsa e iniziando una crisi finanziaria di vastissime proporzioni tuttora fuori controllo;
- 2) sebbene, contrariamente alle previsioni degli esperti, l’occupazione sia cresciuta (per il maggiore ingresso delle donne e dei giovani e si considera che buona parte della popolazione in età di lavoro, ma ufficialmente non attiva, invece produce qualcosa specie nell’agricoltura e nei servizi), il reddito ufficiale – quello che è determinante per le pensioni a ripartizione – si è contratto;
- 3) l’effetto delle minori pensioni che dipendono dall’andamento del reddito ufficiale è stato, quindi, pesantemente negativo, sui consumi, vale a dire sulla quantità e sulla qualità dei beni e dei servizi domandati dagli anziani.
Questi ultimi, infatti, tendono a domandare – quando ne hanno la possibilità – servizi e beni di maggiore qualità e maggior pregio: allora, più e migliori sono le prospettive di occupazione e di reddito dei giovani. Il cosiddetto conflitto intergenerazionale, allora, è solo frutto della fantasia malata di chi determina politiche economiche sbagliate perchè tutte squilibrate dal lato della finanza. Anche in Italia gruppi di giovani, di anziani, prime avanguardie di movimenti politici e culturali stanno fornendo una riflessione sui cambiamenti necessari per restituire alla moneta ed alla finanza la loro naturale funzione strumentale e ad una strategia di investimenti produttivi, il suo ruolo di trascinamento del progresso e della civiltè.
PENSIONI OBBLIGATORIE, MERCATO DEL LAVORO E RENDIMENTI DEL CAPITALE
(RELAZIONE DEL SINDACO DI BRUXELLES)
PREMESSE
Le riflessioni che seguono sono dedicate a due aspetti: la relazione tra andamento del mercato del lavoro e sostenibilità del sistema pensionistico, l’armonia o le difformità tra rendimenti dell’economia reale e di quella finanziaria. Tra i due aspetti esistono molti legami, sia che si parli di pensioni a ripartizione o PAYG (pay as you go), sia che si parli di pensioni a contribuzione e a capitalizzazione.
Il lavoro di BARR (1) ha contribuito notevolmente a sfatare alcuni miti in materia pensionistica, specie sottolineando come le circostanze esterne – occupazione e produttività, ad esempio, piuttosto che trends demografici o rendimenti, finiscano per rendere meno importanti le differenze tra i sistemi (PAYG o a capitalizzazione) per la loro “governance”. E, pur ponendosi sulla falsariga di BARR, potrebbe dirsi che la differenza forse maggiore tra PAYG e capitalizzazione sta nel fatto che, nella prima, la sostenibilità sociale passa per quella finanziaria (col risultato che è più facile ottenere obiettivi di politica economica con interventi di finanza di natura redistributiva); mentre, nella seconda, la sostenibilità sociale deve essere stabilita a priori, nel senso che rendimenti insoddisfacenti del capitale nel lunghissimo termine, ovvero gradi di copertura molto miseri, possono portare a squilibri ben più gravi di quelli meramente finanziari discendenti da una cattiva gestione di un sistema PAYG.
Una stretta proporzionalità tra versamenti contributivi e pensioni – dato un tasso di rendimento fisso o, comunque, abbastanza costante – richiederebbe, infatti, un mercato del lavoro poco flessibile o, meglio, dove tutti abbiano un percorso professionale omogeneo, continuativo, con basso indice di dispersione di salari e stipendi.
A tale condizione, infatti, le differenze tra PAYG e capitalizzazione si ridurrebbero all’efficienza finanziaria dei tassi di rendimento del capitale a lunghissimo termine, ovvero si annullerebbero nella convergenza tra il rendimento PAYG e la media di quello a capitalizzazione. In un mercato del lavoro molto flessibile e precarizzato, infatti, occorrerebbe prevedere una pensione minima, in certi casi inversamente proporzionale al reddito, ed una pensione integrativa obbligatoria, in parte destinata a sostenere solidaristicamente quella minima (nulla vieterebbe, poi, l’esistenza di risparmio volontario con agevolazioni fiscali non troppo forti e non troppo forti ulteriori trasferimenti alle pensioni minime, attraverso la gestione di detti flussi finanziari volontari).
E’ stato calcolato, ad esempio , che, in Italia, alcuni milioni di lavoratori, attualmente giovani con rapporti precari e semidipendenti, in mancanza di interventi, vedrebbero, alla fine della loro esperienza professionale, una copertura pensionistica pari al 30% del loro reddito medio presunto (2). Ciò vale a dire, a valori correnti, 250-300 euro al mese. Una prospettiva del genere non dovrebbe provocare un allarme minore di quello che si manifesta diversi anni fa quando si realizzà che, in presenza di un sistema tutto PAYG, gli occupati e la popolazione si riducevano mentre il numero dei pensionati aumentava. Oggi questo allarme, che ha portato alla riforma Dini (3), potrebbe ridimensionarsi per vari fattori :
- 1) l’apporto e la presenza di lavoratori immigrati;
- 2) la ripresa occupazionale;
- 3) le nuove stime del lavoro femminile;
- 4) gli obiettivi di aumento del tasso di attività della popolazione.
A ciò possono aggiungersi sia le possibilità di allungamento della vita lavorativa, consentita dalle caratteristiche più mentali che fisiche del lavoro stesso al giorno d’oggi e in prospettiva (di qui l’importanza di sceverare adeguatamente tra mansioni stressanti, avvilenti, faticose e pericolose da una parte ed il “grosso” del lavoro mentale); sia, il che è lo stesso, gli incentivi a permanere attivi più a lungo.
Pensioni a capitalizzazione o a ripartizione molto basse, in assenza di un sistema di garanzia del minimo, verrebbero controbilanciate non dalla previdenza complementare, ma dal lavoro irregolare, sommerso, illegale (infatti il livello retributivo di tutto il lavoro regolare, compresi i precari e gli indipendenti, sarebbe troppo basso per consentire adeguate pensioni comunque).
Di qui la necessità di riprendere il filo del discorso dall’inizio, con l’obiettivo, appunto, di evitare il formarsi di situazioni schizofreniche dove, da una parte, ci si batte per l’aumento delle flessibilità e, dall’altra, si considera la previdenza complementare come la panacea; ovvero si impongano alti rendimenti al capitale finanziario e poi ci si lamenti del fatto che le prospettive occupazionali e reddituali non si rivelino rosee.
MERCATO DEL LAVORO E PENSIONE
Come si è già accennato, i sistemi PAYG sono stati sottoposti a critiche, revisioni e attacchi radicali a causa di due, anche concomitanti, evenienze: la loro insostenibilità pratica, l’inadeguadezza dei loro rendimenti. Soprattutto nei paesi industrializzati – ma non solo e non dovunque (4) – il calo demografico e/o occupazionale, nonchè l’aumento della vita media dei pensionati (vedi figg. 1 e 2) hanno suggerito, in alternativa o insieme:
a) l’aumento dell’età alla pensione e delle annualità contributive;
b) la riduzione della copertura ovvero il calcolo della pensione in base alla attualizzazione di tutti i versamenti (cioè un sistema cosiddetto contributivo che, in pratica, è un sistema a capitalizzazione con rendimenti più bassi di quelli dei fondi, ma garantiti).
Contrariamente alle attese, invece, nel corso degli anni ’90 si sono determinati, nel mercato del lavoro, fenomeni contrastanti che, però, sembrano aver molto ridimensionato – seppure non del tutto sopito – gli allarmismi degli anni ’80.
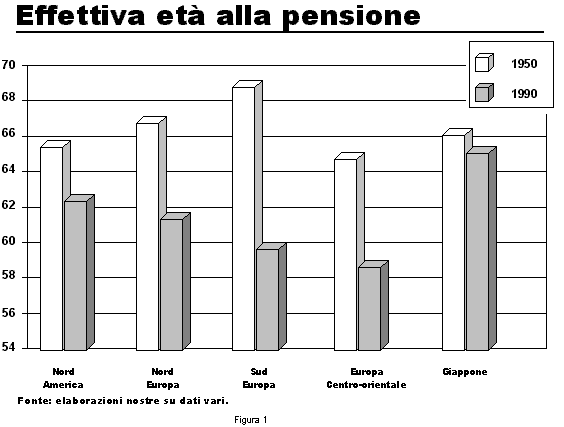
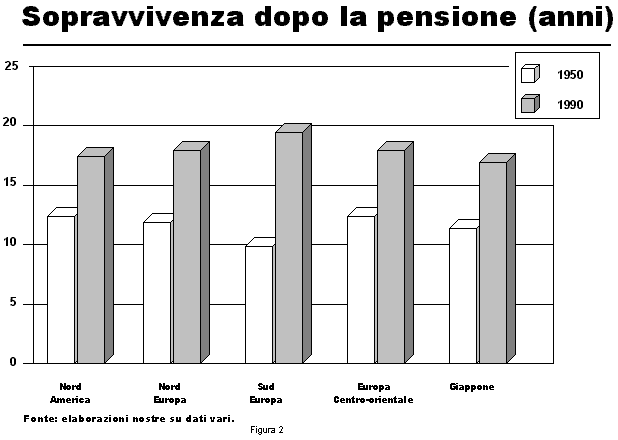
Da una parte, infatti, il numero dei lavoratori dipendenti con paghe nella media delle retribuzioni e oltre si è notevolmente ridotto; dall’altra – e contrariamente alle previsioni più fosche – il numero dei lavoratori con paghe più basse (frutto delle flessibilizzazioni più o meno selvagge) è aumentato in modo più che proporzionale rispetto al precedente.
Il risultato è stato un aumento dell’occupazione notevole (nell’ordine di molte centinaia di migliaia di lavoratori aggiuntivi, almeno in Italia, in parte sottratti alle liste dei disoccupati), ma un’ancora più marcata trasformazione della forza lavorativa nel senso della sua precarizzazione e della riduzione della sua remunerazione media.
Ai fini pensionistici le due cose risultano identiche e la differenza tra modelli trascurabili: alternando lunghi periodi di disoccupazione a periodi brevi di lavoro (o, anche, viceversa) e non intravedendo una rapida e duratura stabilizzazione delle paghe, milioni di persone non avranno una pensione decente. Di qui la necessità di scegliere, prima di tutto, fra varie politiche del lavoro – in quanto il nesso causale sembra andare, in genere, da lavoro a pensioni e non viceversa – finalizzate o meno alla stabilizzazione del lavoro stesso (pur dopo una fase di inserimento per i più giovani che può risultare anche estremamente flessibilizzata).
I problemi che sembrano manifestarsi, oggi, possono così – seppur brevemente – riassumersi in base alle fasce di età: cinquantenni che le imprese considerano troppo pagati e troppo poco aggiornati, i quali vengono espulsi almeno 6-7 anni prima del maturare di una pensione; quarantenni che hanno scarse esperienze lavorative oppure sanno di dover cambiare pur senza capire dove andranno a finire; trentenni (o anche meno) che, dopo aver beneficiato di un qualche ingresso sul mercato del lavoro – pur scambiando un elevato titolo di studio con un salario modesto – si vedono, a loro volta, superati da ventenni con titoli professionali ancora più elevati e pronti ad accettare condizioni ancora più convenienti per le imprese.
In tali circostanze, appare difficile separare il ragionamento sulle pensioni da quello sulle politiche del lavoro. In particolare giova, forse, sottolineare che non tutta la forza lavoro attuale – sempre dividendola in fasce di età come in precedenza – corrisponde alle problematiche evidenziate; ma solo grandi insiemi di essa. Senza la soluzione di tali problematiche, attraverso le azioni positive di un’adeguata politica economica e del lavoro, i sistemi a ripartizione (PAYG) tendono a non raccogliere sufficienti risorse per mantenersi in equilibrio. Ovvero evidenziano il fenomeno per cui sembra che il pagamento delle pensioni correnti ostacolerà quello delle pensioni future. Per quanto appaia ragionevole e, altresì, opinabile ritenere di dover intervenire sul sistema PAYG, sui rendimenti e sull’età alla pensione (in tutte le sue sfaccettature), tuttavia ciò, come minimo, andrebbe ipotizzato dopo aver varato e monitorato adeguate politiche del mercato del lavoro.
I dati italiani degli ultimi due anni, infatti, hanno smentito le più fosche previsioni sull’andamento del rapporto tra spesa pensionistica e PIL (prodotto interno lordo) a lungo termine perchè, in esse, era stato sottovalutato il contributo della componente femminile, forse quello degli immigrati – le cui domande di regolarizzazione a fine 2002 superano le 700.000 – e, certamente, la ripresa occupazionale dell’ultimo biennio.
Senza precisi ed efficaci interventi sul mercato del lavoro, il sistema a capitalizzazione sembrerebbe funzionare adeguatamente per i beneficiari, ma al prezzo di aggravare le disparità sociali. E’ questo il punto dove il modello elaborato dalla Banca Mondiale nel 1998 soprattutto per la Russia (5) sottovalutava le connessioni tra andamento del mercato del lavoro, sostenibilità sociale e sostenibilità finanziaria; piano che poi, correttamente, è stato ritirato.
SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
Per i beneficiari, come si diceva, il sistema a capitalizzazione sembrerebbe adeguato; ma, per esserne sicuri, occorrerebbe ipotizzare un rendimento del capitale abbastanza elevato e costante nel lungo e nel lunghissimo termine (30-40 anni).
In questo paragrafo, seppur brevemente e sommariamente, si cercherà di riflettere su ipotesi di convergenza contro ipotesi di divergenza tra elevatezza e costanza dei rendimenti nonchè sugli effetti (dei comportamenti degli operatori) dei fondi pensione sul mercato del lavoro e sull’economia.
Dal punto di vista del risparmio, nel lungo e nel lunghissimo termine, l’esperienza (molto più della teoria) ha dimostrato che periodi di elevata remunerazione dei titoli azionari si alternano con periodi di elevata remunerazione delle obbligazioni, ma anche con crisi, cracks e cali nei rendimenti azionari stessi e periodi di scarsa remunerazione delle obbligazioni; ciò significa – anche introducendo più elementi di valutazione e “prodotti finanziari” sofisticati – che, empiricamente, i rendimenti sono variabili mentre la costanza non esiste, esiste solo la media dei rendimenti nel tempo.
Quest’ultima, però, uscendo un tantino dall’empiria, non può discostarsi dall’andamento della produttività; e il punto è che, nel breve termine e nella micro-economia, gli investimenti possono spostarsi da un’attività all’altra; viceversa, nel lungo termine e nella macroeconomia, la produttività che conta è quella del sistema nel suo complesso. Se tutta la forza lavoro attende una certa remunerazione del proprio risparmio, farà testo per giudicare l’adeguadezza del sistema, quello che accade nella media, vale a dire nell’insieme. In tale sede – lungo e lunghissimo termine, economia nel complesso – può accadere, nella migliore delle ipotesi, che il rendimento dei due sistemi (capitalizzazione e PAYG) sia uguale.
Nelle peggiori, invece, come si è visto, il PAYG è influenzato dall’andamento dell’occupazione e delle retribuzioni anche queste al netto degli abbagli inflattivi e, quindi, (funzione della produttività), mentre la capitalizzazione risente – macroeconomicamente parlando – della diffusione dei guadagni di produttività.
Come dire: se l’economia ristagna, se il campo delle innovazioni tecnologiche si limita ad una percentuale modesta della produzione, se gli investimenti nelle grandi infrastrutture sono limitati da considerazioni finanziarie di disponibilità di somme, se la ricerca di elevati saggi del profitto nella gran parte delle imprese dove i rendimenti sono decrescenti implica tagli nell’out put (minori di quelli degli in put ), è difficile che la generazione futura veda confermato e difeso – a maggior ragione allargato – il valore del proprio risparmio in termini di beni e servizi acquistabili. Meriterebbe di essere approfondito l’ultimo dei possibili fenomeni prima accennati, vale a dire la massimizzazione del saggio del profitto ovvero una sua elevata programmazione all’inizio del ciclo del prodotto imposta dai proprietari – e, quindi, principalmente dagli investitori istituzionali – ai managers.
Il fatto è che simili obiettivi appaiono compatibili con lo sviluppo economico (e, quindi, il mantenimento di un’adeguata remunerazione per tutto il risparmio nel lungo e lunghissimo termine), solo nel caso dei settori o comparti o aziende caratterizzati da forte innovazione ed espansione sul mercato. Qui, infatti, i rendimenti sono crescenti e non c’è divergenza di trend tra il volume dei profitti e il saggio del profitto. Come dire: se i rendimenti sono crescenti, anche la domanda di in put lo è; più si investe e maggiori sono i profitti. Ma una parte consistente dei settori, dei comparti e delle imprese (dipende da paese a paese, da situazione a situazione) presenta rendimenti decrescenti o, nella migliore delle ipotesi, costanti.
Se i rendimenti sono decrescenti, il saggio del profitto che interessa l’investitore o proprietario aumenta o si mantiene solo se la riduzione degli input è maggiore di quella dell’out put (ovvero se, a parità di quest’ultimo, la quantità di in put diminuisce). Mentre la ricerca di efficienza in termini economici e produttivi stimola quella crescita che è fondamentale per la valorizzazione del risparmio sul lunghissimo termine, la ricerca di efficienza finanziaria (semplificata qui, nell’obiettivo di far aumentare il saggio del profitto) soddisfa le esigenze dei risparmiatori nel breve termine, ma mina le prospettive della crescita stessa nel lungo.
Di per sè, dunque, tutto dipende dall’andamento dell’economia reale, ma quest’ultima appare fortemente condizionata dagli obiettivi dei risparmiatori-proprietari-investitori nel breve termine; ne consegue che il modello pensionistico migliore è quello che interferisce di meno con lo sviluppo economico quando i vincoli e le considerazioni finanziari si trovino in contrasto con le esigenze di crescita reale e produttiva.
ALTERNATIVE: IL MODELLO INPDAP?
Il PAYG è un modello mutualistico (con basso, ma costante “profitto”) così come la capitalizzazione è un modello individualistico a “profitto” variabile e con elementi di rischio che influiscono sulla continuità del rendimento.
Se, dunque, l’obiettivo di “governance” è – nel caso del PAYG – di orientare le variabili (occupazione e stabilità del lavoro, rendimenti, ecc.) per assicurarsi la sostenibilità finanziaria, nel caso della capitalizzazione esso dovrebbe risultare quello di identificare un ragionevole punto di equilibrio tra reddività o, meglio, rischio e continuità o, meglio, stabilizzazione dei rendimenti.
Per la capitalizzazione, un tale obiettivo richiede, soprattutto nell’ipotesi di un sistema – a capitalizzazione – obbligatorio (ma il discorso vale anche per il volontario), che gli aderenti rinuncino sistematicamente ad una parte nella remunerazione del loro risparmio.
Una circostanza difficile da giustificare o da sostenere senza un’insiemizzazione degli aderenti in base alla loro propensione o avversione al rischio, oppure una nuova proposta che sostituisca punti di rendimento finanziario con altre attività (non finanziarie).
I fondi di investimento, ad esempio, funzionano così o dovrebbero funzionare così, sicchè sembrerebbero dividersi in due grandi categorie: quelli tradizionali e quelli “etici”.
Nel primo caso, l’obiettivo del sottoscrittore è il guadagno (espresso, ovviamente, in percentuale dell’investimento); ma la sua massimizzazione ha creato nel decennio passato non pochi problemi. Abbiamo visto in precedenza come gli investitori istituzionali che vogliono massimizzare i saggi di profitto, o, peggio, vogliono definirli all’inizio del ciclo produttivo, finiscano per influire negativamente sugli equilibri economici che, poi, contribuiscono a destabilizzare quelli finanziari.
Inoltre, quando la redditività finanziaria si riduce e una situazione di crisi o di ristagno avanza, l’avversione al rischio di taluni insiemi di risparmiatori non determina necessariamente una stabilizzazione dei rendimenti stessi a un livello più basso, seppure positivo, ma perdite. Questo accade perchè gli operatori assicurano rendimenti più contenuti ai risparmiatori avversi al rischio, ma durante i periodi di boom azionario non comperano obbligazioni nemmeno per loro; e quando il trend si modifica hanno difficoltà a mantenere gli stessi rendimenti obbligazionari del periodo di boom.
L’altro tipo di fondo a capitalizzazione che si è definito “etico”, punta ad una maggiore stabilità dei rendimenti in cambio di un sacrificio che viene giustificato per la scelta di investimenti socialmente e solidaristicamente qualificati. Così, l’individualismo di questi fondi a capitalizzazione si stempera in una forma di altruismo che presenta finalità condivisibili pur senza modificare la natura della contraddizione tra economia reale ed economia finanziaria.
Quest’ultima, infatti, aumenta i vincoli e riduce i gradi di libertà per la prima; sicchè quella reale poi incontra diverse difficoltà e le scarica sugli equilibri finanziari.
Una proposta alternativa potrebbe, allora, esser quella di introdurre elementi mutualistici – invece che altruistici – negli stessi schemi a capitalizzazione; come dire: rendimenti più bassi, ma costanti, e offerta di servizi gratuiti o a costi vantaggiosi per gli aderenti in funzione delle loro esigenze.
Nell’ambito dei sistemi PAYG – in corso di riforma “contributiva” (che, si è detto in precedenza, tende alla capitalizzazione) – una tale impostazione corrisponde all’esperienza dell’INPDAP dove, agli assicurati e ai pensionati, sono offerti servizi importanti a prezzi agevolati o semi-gratuiti: piccoli prestiti, mutui per la casa, vacanze in idonee strutture turistiche, soggiorni all’estero per i figli degli iscritti che vogliono imparare le lingue, borse di studio, promozione di esperienze lavorative.
In uno schema a capitalizzazione, tale “modello” consentirebbe di scambiare quella componente di reddito che innesca un forse eccessivo innalzamento del rischio, con l’acquisto di sevizi utili e necessari a prezzi di convenienza, gratuiti o semi-gratuiti a seconda dei casi.
Si tratterebbe, pertanto, di una vera e propria ottimizzazione, dove la perdita di valore finanziario, anche se pari al beneficio mutualistico (in termini di beni e servizi aggiuntivi disponibili), si accompagnerebbe ad una riduzione del rischio che è, di per sè, già un guadagno.
NOTE:
(1) N. BARR, la riforma delle pensioni: miti, verità e scelte normative, Diritto ed Economia dello Stato sociale, n. 2 del 2002, p.9.
(2) M. BENETTI, The italian Pension System, in ISSA, European regional meeting, New and revised approa ches to social protection, Budapest 13 – 15 novembre 2002.
(3) Per un’equilibrata valutazione della situazione vedi INPDAP, Annual Report on the Welfare State 2001, Roma 2001, p. 158 e sgg.
(4) La struttura demografica degli USA indica un’espansione positiva, sicchè la parte a ripartizione dei suoi sistemi pensionistici ha subito attacchi più lievi rispetto a ciò che è accaduto in Europa.
(5) BARR, cit., p. 30.
